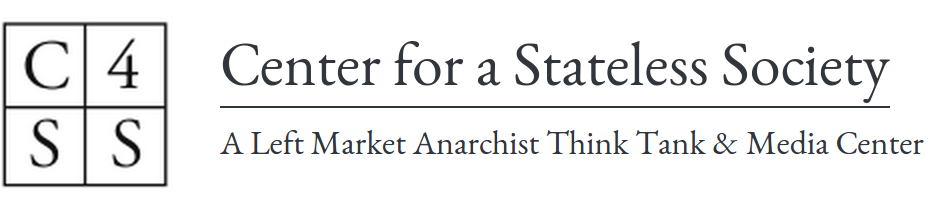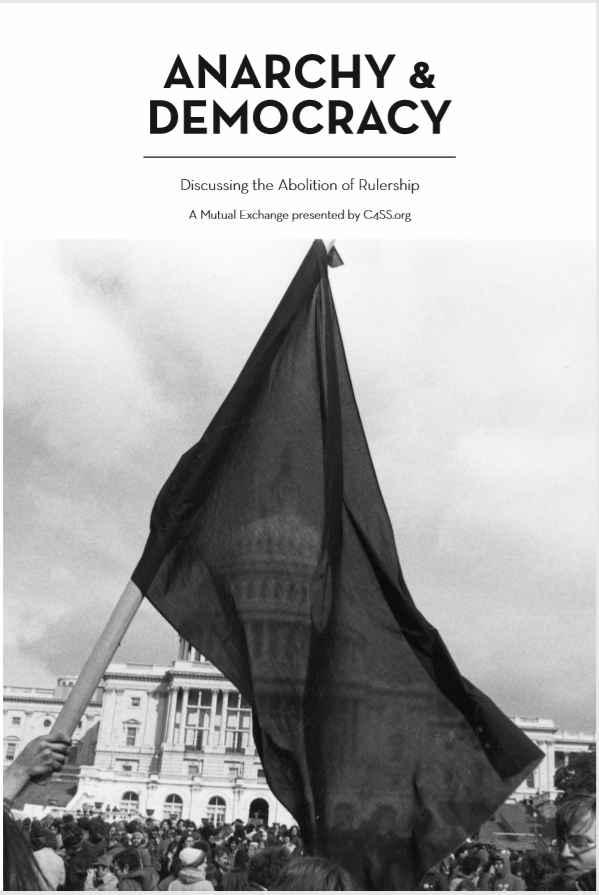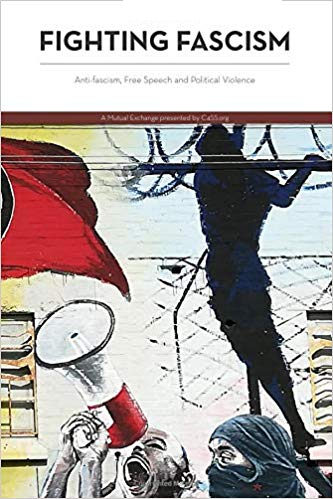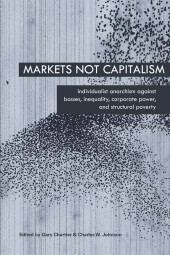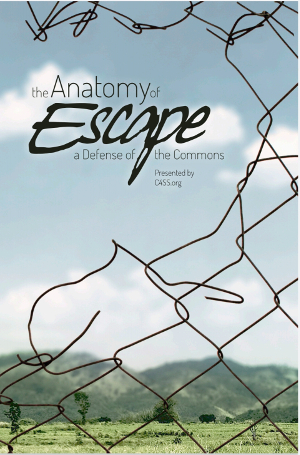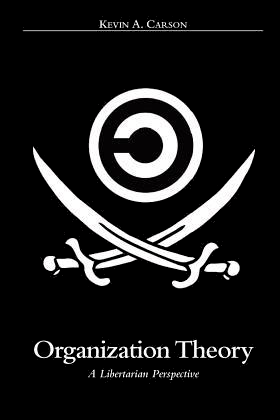Di Kevin Carson. Originale pubblicato il 21 febbraio 2019 con il titolo One Cheer – More or Less – For the Green New Deal. Traduzione di Enrico Sanna.
Prima di fare un’analisi critica da un’angolatura anarchica di una proposta politica come il New Deal Verde, è bene che spieghi quali sono i miei assunti di base. Io non sono un insurrezionalista, non credo che la transizione oltre il capitalismo e lo stato sarà prima di tutto quello che Erik Olin Wright definiva un processo “di rottura”. Forse la fase finale comporterà qualche evento di rottura, ma il resto sarà perlopiù una ratificazione post facto di trasformazioni accumulatesi nelle pieghe del sistema.
Gran parte di queste trasformazioni verrà dall’opera di persone qualunque che mettono su, uno dopo l’altro, i blocchi della nuova società, blocchi che si moltiplicheranno orizzontalmente, fino a coagularsi in un ecosistema fatto di istituzioni alternative, espandendosi e prendendo il posto del vecchio ordine.
In parte questo avverrà grazie a pressioni politiche interne ed esterne volte a rendere più duttile l’atteggiamento dello stato. E in parte sarà il prodotto inconsapevole della lotta tra le varie parti dello stato, nonché dell’utilizzo dei suoi stessi meccanismi interni al fine di sabotarlo.
In parte ci sarà la collaborazione di forze amiche all’interno del mostro. Ci sono persone dentro le istituzioni statali e capitaliste che simpatizzano con le nostre lotte e che sono disposte a mantenere contatti informali, passare informazioni, sfruttare la loro posizione per far funzionare le cose a nostro favore. Come è avvenuto con la transizione dal feudalesimo al capitalismo, alcune entità organizzative, ora incorporate in entità statali e capitaliste, continueranno ad esistere in una società post-capitalista, ma con caratteristiche e relazioni con l’ambiente circostante completamente diverse. Alcuni esempi di quella che potremmo chiamare “corruzione interiore della bestia” si trovano in calce a vari libri di Paul Goodman.
Molto, secondo me, verrà dai tentativi, soprattutto a livello locale, di volgere lo stato in una direzione meno statale: una regola generale delineata per la prima volta da Saint Simon e riassunta nell’espressione “amministrazione delle cose e non degli uomini”, e da allora riciclata con tutta una serie di etichette che vanno da “scioglimento dello stato nel corpo sociale” a “stato wiki” a “stato partner”. Penso, ad esempio, ai movimenti municipalisti di Barcellona, Madrid, Bologna e Jackson, oltre ad altre decine e centinaia che replicano il modello in tutto il mondo, ma anche particolari forme istituzionali come alcune cooperative agricole e vari modelli economici locali basati sui beni comuni.
Non esiste il pulsante magico che fa scomparire lo stato. Lo stato ha occupato le vie e i canali (per parafrasare Paul Goodman) attraverso cui avvengono molte funzioni sociali indispensabili. Finché esiste lo stato, vorrei che il suo intervento sulla società e l’economia fosse il meno orripilante possibile, e che le funzioni sociali indispensabili di cui ha assunto il monopolio fossero svolte nel modo più umano e tollerabile possibile durante la transizione verso la socializzazione; il che significa riportarle sotto un vero controllo sociale attuato in forma cooperativa e associazionistica e non costrittiva. Vorrei che lo stato fosse sottoposto a quelle che André Gorz definiva “riforme non riformiste” che pongano le basi di un’ulteriore trasformazione, che facciano da ponte verso una società radicalmente diversa.
Prendiamo il caso di un cambio climatico catastrofico, in cui è giustificata l’imposizione di un’etica d’emergenza e la chiusura di pericolose attività economiche. Con l’attuale stato normativo è lo stato stesso che si assume il monopolio dell’azione, e questo potrebbe essere un bene soprattutto se colpisce certe entità, come le aziende che abusano dei loro poteri e dei privilegi garantiti dallo stesso stato: questo, nell’immediato, potrebbe rappresentare il meno peggio. Visto che lo stato ha creato e sostenuto attivamente un modello economico che minaccia la biosfera, un intervento dello stesso stato, anche parziale, che ponga un argine e inverta la tendenza è forse tra tutte le forme d’intervento quella che meno mi turba il sonno.
Prendiamo ad esempio un fatto di un decennio fa, quando, vista la tendenza cronica del capitalismo aziendale al capitale in eccesso e alla capacità produttiva inutilizzata, per evitare una depressione Obama varò un pacchetto di stimoli. Dovendo proprio spendere, avrei preferito che quelle centinaia di miliardi fossero stati spesi in infrastrutture di base che facessero da ponte verso un modello economico meno distruttivo. Ricordo di aver letto che con due o trecento miliardi, un terzo del pacchetto, sarebbe stato possibile eliminare i colli di bottiglia del sistema dei trasporti ferroviari e trasferire su rotaia l’80% del traffico merci gommato, riducendo le emissioni dei trasporti di lunga distanza ad una frazione del valore. Obama decise invece di distribuire soldi per progetti “immediatamente fattibili”, il che significava progetti infrastrutturali già promossi e approvati dagli interessi immobiliari locali e da altri componenti della Macchina della Crescita, al fine di favorire un’ulteriore espansione del modello culturale basato sull’automobile, i sobborghi e la zonizzazione.
Se per evitare una depressione era proprio necessaria una forte spesa deficitaria, sarebbe stato molto meno statalista, invece di dare soldi ai redditieri perché acquistassero buoni fruttiferi, utilizzare il denaro senza interessi secondo le linee consigliate dalla moderna teoria monetaria, o realizzando direttamente opere statali o ancora depositando i soldi nei conti dei cittadini sotto forma di dividendo di cittadinanza. Sarebbe stato meno statalista fare un alleggerimento quantitativo non sulla base dell’attuale modello, per cui la banca centrale autorizza le banche ad espandere la base monetaria creando dal nulla denaro da prestare ad interesse, ma creando denaro da distribuire come reddito di base. Sarebbe stato meglio dare quei soldi alle banche a condizione che ribassassero i mutui in default al loro valore di mercato e rifinanziandoli a termini più abbordabili. Questo tanto per dirne qualcuna.
Arriviamo al New Deal Verde.
Tornando al principio di prima, per cui se proprio lo stato deve intervenire preferisco che lo faccia nel modo meno schifoso possibile, è meglio che lo stato spenda quei soldi per invertire almeno in parte la tendenza ad un’ingegneria sociale basata su incentivi al sistema autostradale e ai trasporti aerei, e di interventi che diffondono la cultura dell’automobile.
La questione è: fino a che punto il New Deal Verde va in questa direzione?
Quando propone di passare da un sistema di trasporti stradali e aerei sovvenzionato dallo stato ad uno basato sui trasporti pubblici cittadini e ferroviari per pendolari, quando propone di ridurre il consumo di combustibili fossili per passare alle energie rinnovabili, credo che questo, data la realtà, sia praticamente il meglio che ci si possa aspettare dallo stato nell’immediato futuro.
Il New Deal Verde, così come proposto da Michael Moore, Jill Stein e Alexandria Ocasio Cortez, ha due difetti strutturali. Primo, dà per scontato l’attuale consumo energetico, vuole che si produca la stessa energia ma senza combustibili fossili.
Tanto per esemplificare, così Alex Baca commenta un parcheggio coperto a Berkeley:
“Ha i pannelli fotovoltaici e i punti di ricarica delle auto elettriche, un impianto di depurazione e riciclaggio e il car-sharing”; per non dire dei 720 posti auto. È costato quasi quaranta milioni. La notte sfavilla di luci. Ed è a un tiro di schioppo dalla stazione della Bart.
Se la città nota come la più progressista d’America, una città in cui quasi tutto è a due passi, spende quaranta milioni per rinnovare un parcheggio coperto ad un tiro di schioppo da una stazione, significa che i democratici non hanno alcuna intenzione di affrontare seriamente la questione climatica.
Ad onor del vero, la Ocasio Cortez auspica il trasferimento di una grossa porzione di fondi dalle autostrade ai trasporti pubblici. Ma pare molto più orientata all’eliminazione dei combustibili fossili dalle centrali elettriche che ad un diverso modo di impiegare l’energia.
Il New Deal Verde, spiega Baca, “ha un neo enorme”:
Non prende in considerazione lo spazio in cui vivono gli americani. Più di ogni altra cosa, fondamentale al fine di un futuro ecologicamente migliore è lo spazio geografico: dove dormiamo, lavoriamo, preghiamo, facciamo acquisti, giochiamo; e come ci spostiamo tra questi luoghi. La proposta ha tutte le illusioni dei liberal riguardo il cambio climatico: pensano che la tecnologia e la spesa possano risparmiarci la fatica di cambiare il sistema.
Baca cita in particolare il modello urbano incentrato sull’auto; un modello promosso da decenni di ingegneria sociale da parte dell’industria dell’auto e degli interessi immobiliari in combutta con gli urbanisti; un modello che racchiude gli spazi residenziali, commerciali e lavorativi in enclave a destinazione unica separate ma connesse tra loro da tutto un sistema stradale. Prima di tutto, occorre tornare a quel tessuto urbano prevalente prima dell’avvento dell’auto privata: centri compatti con un insieme di abitazioni e attività economiche, in cui le persone possono andare al lavoro o a fare la spesa a piedi, in carrozzina, in bicicletta, in autobus o col tram. Più che di auto elettriche che sostituiscano quelle a combustione interna, più che di pannelli solari che sostituiscano le centrali a carbone, abbiamo bisogno di fare meno chilometri e consumare meno energia.
L’accento che Baca pone sul tessuto urbano, però, per quanto giusto non basta affatto. Altrettanto importante è l’organizzazione industriale; occorre riportare la produzione a livello locale, cambiare il modo in cui produzione e distribuzione sono organizzate.
C’è una combinazione fatta di grossi incentivi al consumo energetico e ai trasporti, barriere all’ingresso che promuovono la cartellizzazione e permettono agli oligopoli economici di scaricare gli sprechi e le inefficienze sui prezzi, socializzazione dei costi di numerosi input produttivi materiali e sociali, e diritti di proprietà artificiali come marchi commerciali e brevetti che facilitano il controllo legale della vendita dei prodotti la cui produzione è appaltata a società estere. A causa di tutto ciò, ci ritroviamo con aree di mercato e catene di fornitura e distribuzione così ampie che, se i costi fossero sostenuti dalle aziende capitaliste, sarebbero di gran lunga inefficienti. Anche quando la produzione, a livello di impianto, è razionalizzata, snella, su richiesta, il fatto che esista una catena distributiva transoceanica significa che il vecchio schema produttivo supply-push è stato semplicemente nascosto sotto il tappeto; tutti i calcoli sulle giacenze, tutti gli inventari dei prodotti finiti che caratterizzavano la produzione sloanista sono stati trasferiti su quei magazzini a quattro ruote che sono i tir e sulle navi portacontainer.
Insomma, occorre riportare la produzione a livelli locali sulla falsariga dei modelli descritti da Kropotkin, Mumford e Borsodi, così da cogliere i vantaggi offerti, e a suo tempo ignorati, dall’introduzione della macchina elettrica durante la seconda rivoluzione industriale. Serve una produzione industriale di basso livello fatta di officine di comunità o di quartiere, con macchine multiuso a controllo numerico che producano per il mercato locale, facilmente adattabili in tempo reale alle più svariate richieste. Questo eliminerebbe non solo gran parte dei costi di trasporto incorporati nell’attuale sistema, ma anche i costi aggiuntivi associati al marketing di massa perché la produzione non tiene conto della domanda, nonché il costo degli sprechi (obsolescenza programmata, industria delle armi, cultura dell’auto e dei sobborghi, eccetera) generati per ovviare alla capacità produttiva inutilizzata.
Fare “infrastrutture” di per sé non è progresso. È progresso solo quando è compatibile con cose come la produzione a livello locale e la sostituzione della cultura dell’auto con le comunità a destinazione promiscua.
Secondo, il New Deal Verde, nello spirito del New Deal originale, punta a salvare il capitalismo. È un programma anti-deflazionistico che punta a creare nuovi sfoghi per i lavoratori e i capitali in eccesso offrendo un “posto di lavoro” a tutti. Non vuole capire che il progresso tecnologico ha drasticamente ridotto il bisogno di manodopera e materie prime necessarie a garantire uno stile di vita elevato, rendendo possibile una distribuzione equa dei risultanti benefici e del tempo libero.
Questa volontà salvifica sta al centro del New Deal Verde proposto qualche anno fa da Michael Moore, così come della versione attuale di Alexandria Ocasio-Cortez.
Secondo Wikipedia, l’espressione “New Deal Verde” è opera di Thomas Friedman, che immaginava un modo per “creare una nuova industria pulita che proiettasse l’economia nel ventunesimo secolo”. Da allora, la nascita di industrie “verdi” che creano tanti “posti di lavoro” è al centro della propaganda del New Deal Verde. Rappresenta, più in generale, il cuore del paradigmatico “capitalismo progressista” o “capitalismo verde” promosso da Warren Buffett, Bill Gates e simili. L’idea è di utilizzare le nuove tecnologie per combattere il problema cronico delle eccedenze di capitale che non generano profitti, ingabbiare tali tecnologie così da poter generare nuovo profitto, utilizzarle per creare nuove industrie e nuove infrastrutture di supporto che possano alimentare un nuovo “motore dell’accumulazione” o una nuova “onda di Kondratiev” che possa succhiare capitali per un’altra generazione o giù di lì. La creazione di nuove industrie servirebbe a “contrastare” la tendenza al calo del saggio di profitto descritto da Marx nel terzo volume del Capitale.
Suppergiù questo è lo stesso sogno di Michael Moore: facciamo andare al massimo le vecchie fabbriche, rimettiamo al lavoro milioni di lavoratori per produrre autobus e treni ad alta velocità, mentre altri milioni producono pannelli solari e centrali eoliche. Il fatto è che le tecnologie produttive sono sempre più economiche e effimere e questo rende superflua una parte crescente ad un tasso tale per cui la produzione di autobus, treni e pale eoliche ha un impatto risibile. E comunque, gran parte dell’attuale produzione è uno spreco che deve essere semplicemente eliminato, non prodotto con energia alternativa. Se, da un lato, sostituire gli attuali indispensabili sistemi di trasporto con altri più puliti è una buona idea, dall’altro resta il fatto che gran parte dell’attuale sistema di trasporti è inutile e andrebbe eliminato cambiando il tessuto cittadino e la dislocazione delle attività produttive. Gli autobus e i treni potrebbero dare una boccata d’aria pulita, evitando la produzione di nuove automobili, per qualche anno al massimo.
Non esiste un modo semplice per investire quanto serve per produrre energia alternativa, treni e trasporti locali, così da garantire un posto da quaranta ore settimanali, rimettere in moto le linee d’assemblaggio di Detroit, ed evitare che i più poveri precipitino fuori dai mercati dei capitali, il tutto senza enormi sprechi produttivi.
Se la Ocasio-Cortez e i suoi amici vogliono tenere petrolio e carbone sottoterra, promuovere l’uscita dai combustibili fossili e porre fine agli incentivi alla cultura dell’auto, sono con loro. Quanto ai “lavori verdi sicuri”, la promessa di una crescita economica fatta di nuove “industrie verdi”, e altri approcci simili volti a prolungare la sopravvivenza del capitalismo, tutto ciò è un vicolo cieco.
Cosa resta? Cosa fare nel frattempo?
Quando elaboro un’alternativa, io parto dal principio secondo cui il nostro obiettivo principale è l’edificazione di una società post-capitalista, e se a tal fine collabora anche lo stato ha un’importanza secondaria. Il primo obiettivo è la creazione di un ambiente meno ostile, più favorevole, su cui edificare il resto. Se volete votare per limitare i danni, per cercare di spingere lo stato in una direzione ecologicamente meno dannosa, o per spostare gli attuali interventi verso ambiti ecologicamente migliori, che Dio vi assista.
Questo è ciò che intendono Antonio Negri e Michael Hardt in Questo non è un manifesto: qualcosa che sia parte di una strategia simbiotica che combini la sinistra orizzontalista, con la sua pratica di contro-istituzioni prefigurative, e i partiti di sinistra che cercano di influire sulla politica dello stato. Tutto bene finché i movimenti di base, impegnati nella costruzione di una nuova società fuori dallo stato, sostengono quegli attori politici che agiscono nella direzione giusta, o se questi offrono il loro aiuto con azioni di disturbo, creando un ambiente più propizio all’edificazione di una società nuova. Ma è d’importanza vitale mantenere una totale autonomia e libertà d’azione, opporsi a quelle forze che vorrebbero trasformarci in un movimento sociale che faccia da sostegno di un partito politico come Van Jones cercò di fare con Occupy, non lasciare che i partiti di sinistra al governo risucchino energie da chi è impegnato nell’edificazione di contro-istituzioni, come ha fatto Syriza con il movimento Syntagma dopo l’ascesa al potere in Grecia.
Il nostro principale obiettivo strategico deve essere l’edificazione di nuove istituzioni. Ciò è particolarmente importante a livello locale, dove può esserci, o non esserci, un occasionale incontro con le autorità locali.
Fare pressioni sulle amministrazioni locali affinché diluiscano le norme che impongono zonizzazione e proliferazione dei sobborghi, affinché frenino gli incentivi all’allargamento dei centri urbani come la fornitura di servizi a costi ridotti, potrebbe dare i suoi frutti. Ma la strada migliore, se si vuole ridurre le emissioni, passa attraverso la conversione dei sobborghi residenziali e delle aree produttive in comunità a destinazione mista con attività economiche diversificate.
Queste cose saranno sempre più una necessità, man mano che l’esaurimento dei combustibili fossili e gli sforzi fatti per tenere in piedi l’attuale economia, combinati, renderanno proibitivo il pendolarismo per un numero crescente di persone; allo stesso tempo saranno disoccupazione, sottoccupazione e precariato a spingere sempre più persone a sostituire il lavoro salariato con la produzione di beni per il mercato locale.
Quanto alle azioni strategiche che promuovano la riduzione delle emissioni, un’azione diretta volta a rendere non redditizie le industrie tradizionali è tanto importante quanto una qualunque iniziativa “carbon free” a livello locale. Impedire fisicamente la realizzazione di un oleodotto, servirsi di cavilli legali e burocratici per sabotarli con le loro stesse normative, disinvestimenti, sabotaggio delle centrali di pompaggio e di altri punti vulnerabili, tutto ciò fa ben sperare che si possa rendere tali progetti sempre più a rischio, diminuendone l’attrattiva economica e accelerando la transizione verso un’economia pulita.
E sono le persone impegnate nella creazione di micro-manifatture, hackerspace, orti di quartiere, monete locali, banda larga locale, occupazioni di edifici e terreni inutilizzati, cooperative agricole, progetti di coabitazione, condivisione di attrezzi e altre iniziative concrete, sono proprio loro a edificare una società senza sprechi e con energia sostenibile.
Per concludere, credo che sia un errore riporre le speranze in un partito o in celebrità progressiste come Bernie Sanders o Alexandria Ocasio Cortez, per quanto siano meglio della media. Le mie speranze riguardo una collaborazione con la politica a qualunque livello sono molto modeste. Un partito, che siano i millenari del partito democratico, i verdi o i socialdemocratici, non è lo strumento con cui edificheremo una società post-stato e post-capitalista degna d’essere vissuta. Il nostro obiettivo principale, il più fattibile, è semplicemente utilizzare una qualunque nullità opportunistica con probabilità d’essere eletta per ricacciare indietro la minaccia fascista e prendere tempo. Tutt’al più, nella migliore delle ipotesi (e questo è perlomeno plausibile visto lo spostamento demografico sia del paese che del partito democratico verso i millenari di sinistra), possiamo sperare in uno stato balia che offra un capitalismo molto meno aggressivo, di tipo socialdemocratico, che favorisca un ambiente relativamente tranquillo in cui operare.
Ma se volete farvi un’idea del futuro, guardate cosa si sta facendo in concreto. Come dice un personaggio in Woman on the Edge of Time di Marge Piercy, a fare la rivoluzione non erano i partiti in uniforme, gli slogan e le adunate di massa; “Erano quelli che lavoravano, e lavoravano la terra. Tutti quelli che cambiavano il modo in cui si acquista il cibo, in cui si crescevano i figli, e li si mandava a scuola… quelli che creavano associazioni diverse, non pagavano l’affitto, non andavano alla guerra, scrivevano, insegnavano e parlavano.”