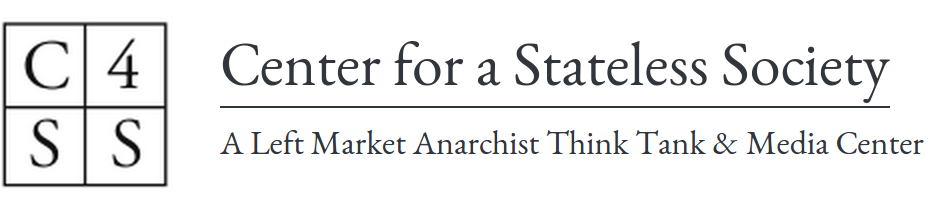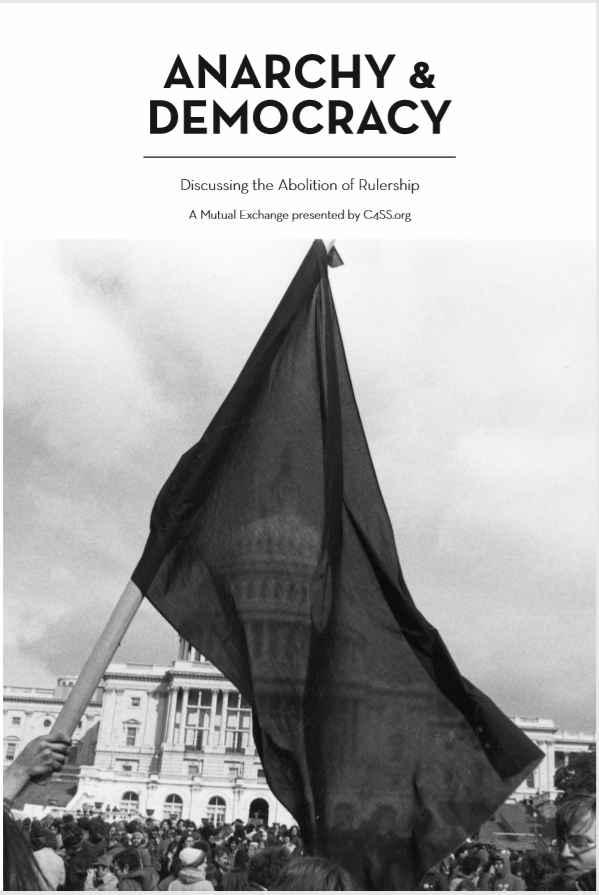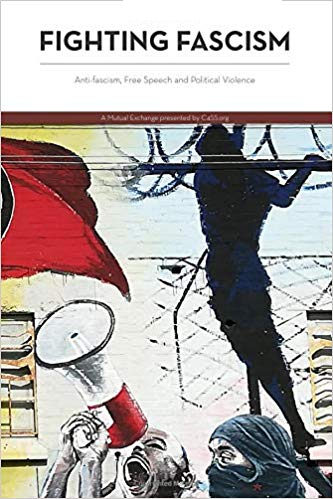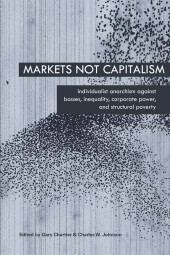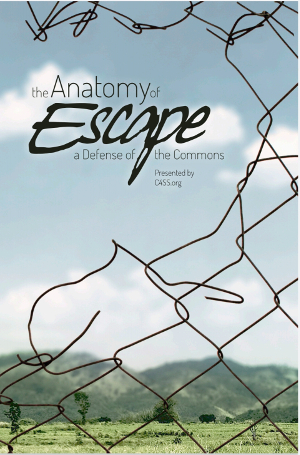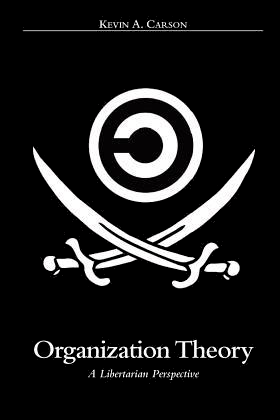Di Alexander Migursky. Originale: Alienation, Deprivation, and Play, del 24 ottobre 2025. Traduzione italiana di Enrico Sanna.
Quando cerchiamo di dare una spiegazione alla paralisi morale che colpisce l’energia rivoluzionaria indispensabile alla nostra sopravvivenza collettiva, un’energia inesistente negli angusti spazi ideologici del realismo democratico, quasi di riflesso torniamo al concetto marxista di alienazione. Un concetto che va oltre l’economia, penetra la struttura profonda della soggettività moderna e abbraccia sia la dimensione psicologica che quella politico-economica.
Secondo Marx, il lavoro è una sorta di oggettivazione della nostra “specie”, delle nostre capacità e dei nostri potenziali.[1] Da qui una separazione da se stessi: il lavoratore dev’essere temporaneamente rimosso dalla realtà a cui cerca di dar forma per essere privato della sua stessa creazione. In un’economia di mercato, questa privazione assume le forme della merce, che diventa lo strumento principale con cui si richiede, si acquista e si vende il lavoro.
Lo scambio delle merci equivale ad una privazione profonda, in quanto la merce non è solo materia ma anche tempo, energia, capacità e vita del lavoratore. La natura, il lavoro, il tempo, il corpo, e anche la soggettività altrui cominciano ad apparire come forze esterne, aliene, che si pongono davanti al lavoratore come forze indifferenti e ostili. L’esperienza corrode tanto l’attività produttiva quanto l’individualità, che per Marx nasce dalla relazione con la dimensione universale della nostra umanità condivisa.
Se tutto ciò che produciamo è destinato a scomparire o ad essere alienato, la nostra capacità di fare, la base della nostra esistenza fisica, diventa ciò che ci qualifica come lavoratori. La nostra sopravvivenza comincia a dipendere da sistemi e forze fondamentalmente in contrasto. Se, come pensa Marx, la natura umana si esprime attraverso l’attività trasformativa nelle sue forme storiche, allora l’alienazione non è più un effetto secondario del capitalismo ma diventa la sua causa principale: l’origine della proprietà privata.
Dunque, col lavoro estraniato, alienato, l’operaio pone in essere il rapporto di un uomo che è estraneo e al di fuori del lavoro, con questo stesso lavoro. Il rapporto dell’operaio col lavoro pone in essere il rapporto del capitalista – o come altrimenti si voglia chiamare il padrone del lavoro – col lavoro. La proprietà privata è quindi il prodotto, il risultato, la conseguenza necessaria del lavoro alienato, del rapporto di estraneità che si stabilisce tra l’operaio, da un lato, e la natura e lui stesso dall’altro.[2]
Ciò che caratterizza il metodo marxiano è il suo tentativo di andare oltre le leggi superficiali dell’economia individuate dai socialisti ricardiani, come la tendenza del lavoro umano a svalutarsi con la crescita della produttività; Marx esplora le origini profonde, antropologiche, dell’alienazione e dello sfruttamento economico. Applicando il materialismo dialettico all’analisi della produzione, sviluppa un quadro concettuale di cui si serve per studiare l’evoluzione delle relazioni sociali, un processo segnato dalla nascita e dal superamento delle diverse forme di alienazione legate strettamente ai cambiamenti insiti nel sistema economico.
Ogni epoca storica ha le sue forme caratteristiche di disagio mentale. Si tratta di disordini che riflettono il modo di produzione dominante, gli strumenti e le tecnologie, e il modo specifico in cui gli individui vivono l’alienazione tramite la perdita di possesso di ciò che producono. Le economie capitaliste stanno entrando in quella che molti considerano la fase terminale. Spinta dalla specializzazione del lavoro, il potere monopolista delle aziende e la virtualizzazione della vita sociale, l’alienazione raggiunge livelli mai visti. Questo perché la logica della produzione permea la vita in tutti i suoi aspetti, trasformando anche le nostre emozioni e le nostre esperienze private in merci per il mercato digitale.
Secondo Marx e Engels, sotto il capitalismo la diffusione mondiale della possibilità di comunicare, pur essendo strumento di dominio, contiene i germi dell’emancipazione. Dà agli oppressi la possibilità di sconfiggere l’alienazione tramite la proprietà collettiva dei mezzi di produzione gestita democraticamente.[3] Il cambiamento dovrebbe teoricamente spianare la strada alla piena realizzazione del potenziale umano.
Ma resta una questione critica da risolvere: come può il lavoro, che per natura aliena ed è alienato nello scambio sul mercato, diventare davvero “libero” mantenendo però una base industriale a sua volta basata sulla divisione del lavoro e sui sistemi politici che lo preservano? Oltre che un’espressione della nostra “specie”, cos’è il lavoro se serve l’intervento continuo nell’autoperpetuante logica della società capitalista per trasformarlo in una prassi emancipatrice? E cosa ci impedisce di pensare che Marx, ontologizzando l’alienazione nel lavoro, non ragioni come quelle persone che lui eufemisticamente definiva “non lavoratori”, ovvero i borghesi?
Primamente è da osservare che tutto ciò che nell’operaio appare come attività di alienazione, di estraniazione, appare nel non-operaio come stato di alienazione, di estraniazione.
In secondo luogo, che il comportamento pratico reale dell’operaio nella produzione e nei confronti del prodotto (come stato d’animo) appare nel non-operaio che gli sta di fronte come comportamento teoretico.
In terzo luogo, il non-operaio fa contro l’operaio, tutto ciò che l’operaio fa contro se stesso ma non fa contro se stesso quello che egli fa contro l’operaio.[4]
Definendo l’esistenza economica “stato di alienazione”, Marx accusa implicitamente il soggetto sfruttato di provvedere al proprio sostentamento irrazionalmente attraverso il lavoro. Ma così facendo dimentica l’“attività alienante”, ovvero quell’insieme di forze esterne che costringono il lavoratore a produrre più di quanto occorre a se stesso e alla sua comunità immediata. Il lavoro implica per natura una relazione pratica, concreta, tra il lavoratore e qualcosa, come e perché questo qualcosa viene fatto; ma Marx lo priva di quelle sottigliezze psicologiche che possono differenziarlo dal gioco o da un generico fare.
Dimenticando le complessità emotive e motivazionali, Marx tratta la relazione tra lavoratore e produzione come “teorica”, ovvero come qualcosa che viene definito interamente dalla logica interna del sistema economico e non dalle intenzioni soggettive o dai conflitti interni. Minimizzando l’importanza dello scambio individuale e della motivazione personale, Marx nega gradualmente al lavoratore quell’autonomia che molti di noi cercano nella vita sociale: la libertà di apprendere, di sviluppare capacità e di offrire il prodotto del nostro lavoro alle nostre condizioni.
Sotto questo aspetto, l’economia politica classica arrivava spesso a conclusioni più accurate riguardo le ragioni soggettive degli attori del mercato. Adam Smith, per esempio, definiva “prezzo reale” di qualcosa lo sforzo che una persona è disposta a fare per ottenerlo. Il calcolo del rischio, inteso come possibile perdita delle proprie risorse, compresi gli strumenti di lavoro, il tempo, la salute, le capacità e anche le proprie convinzioni morali, permette di distinguere tra le diverse attività produttive e di mantenere il lavoro come investimento significativo.[5]
I marginalisti allargarono la definizione del lavoro di Smith fino comprendervi qualunque attività fisica o mentale che, per quanto inizialmente faticosa, si ritiene giustificata da un premio futuro. In quest’ottica le soddisfazioni che il lavoro procura sono poste nel futuro, che si tratti di abilità nel fare qualcosa, risultato, riconoscimento sociale o semplice piacere psicologico. Si fa qualcosa soltanto se il premio futuro compensa le rinunce del presente. In caso contrario l’effetto è negativo: il soggetto si astiene dal lavoro per preservare le risorse che gli restano.[6]
Questa nuova teoria traccia il confine tra fare e lavoro. Mentre il fare è giustificato dal fatto di essere un’esperienza che ricompensa socialmente, moralmente, intellettualmente ed economicamente nel breve termine, il lavoro è definito da una crescita progressiva dei costi morali, sociali, intellettuali e economici che pospongono qualunque soddisfazione indiretta: il lavoro non è espressione creativa di sé ma diventa coercizione. Il lavoro è la forma di impiego più diffusa nel modo di produzione capitalistico, caratterizzato da un dare perpetuo le proprie capacità al padrone del capitale senza il diritto di disporre del prodotto del proprio lavoro.
La storia del capitalismo è accompagnata dall’esproprio dei mezzi di produzione di gran parte della popolazione, proprietà legale e libertà politiche. L’intervento diretto dello stato che ridistribuisce i frutti del lavoro e determina la forma delle organizzazioni economiche secondo una logica di favoritismi di classe, ha spianato la strada all’industrializzazione intensiva, la produzione di massa e il consolidamento delle relazioni di proprietà tramite il diritto esclusivo della proprietà privata. Per gran parte della popolazione, l’innalzamento di barriere d’ingresso nel mercato e l’integrazione forzata nel sistema industriale sono stati l’atto fondativo della moderna esclusione sociale, un taglio netto rispetto ai modi tradizionali di formazione del soggetto.
Secondo Adam Smith, l’esclusione sociale in tutte le forme equivale a negare l’“indispensabile”: quei beni materiali e simbolici il cui possesso è la condizione necessaria della vita piena. Essere esclusi non significa solo non poter accedere alle risorse, ma anche sperimentare un disagio psicologico, un senso crescente di discordanza tra le norme della propria comunità e se stessi. Nel contesto del mercato, questo spiazzamento, esasperato dall’emarginazione economica, di genere, sessuale, nazionale e politica, compromette la capacità di valutare il rischio e fare scelte utili. Accettare di lavorare a queste condizioni non è solo un effetto dell’alienazione strutturale descritta da Marx, ma il risultato di una prolungata privazione sociale che erode le capacità e produce una vita fatta di povertà non solo di strumenti ma anche di possibilità.[7]
Non sorprende che molto malcontento politico delle società attuali nasca dopo l’approvazione di leggi repressive o l’eliminazione di diritti civili. Le privazioni causate dalle politiche discriminatorie non solo riducono la partecipazione politica ma restringono la gamma di opportunità economiche costringendo le persone ad accettare un posto di lavoro in condizioni di sfruttamento in un mercato politicamente rozzo pena l’impossibilità di mantenere un minimo di dignità “umana” nell’ordine simbolico plasmato dal potere statale e aziendale. Diventa sempre più difficile provare orgoglio per il proprio lavoro quando questo, permeato di significato esistenziale, può in qualunque momento essere criminalizzato, superato o distrutto.
A rafforzare ideologicamente la privazione interviene la glorificazione del lavoro e la svalutazione di forme alternative di attività. Al lavoro come produzione coercitiva, o al fare come opera creativa, si contrappone il gioco: un’interazione sociale spontanea valutata per il piacere che dà l’atto in sé, senza guardare ai risultati.[8] Nelle società di classe, il gioco è deduttivamente soppresso al fine di imporre le strutture gerarchiche; “adulti” e “bambini” sono divisi al di là dell’età biologica. Diventare “adulti” significa rinunciare alle attività infantili per dedicarsi al lavoro. Interi campi dell’attività umana devono conformarsi al modello aziendale capitalistico, con i suoi prodotti a domanda elastica, semplicemente per sopravvivere e mantenere una legittimità sociale.
Queste forme di impiego non rafforzano il legame interpersonale né sono inclusive e causano rigetto tanto del lavoro in sé quanto dell’identità adulta, che qui viene percepita come un’accumulazione di esperienze necessarie a valutare i costi delle proprie azioni e di quelle altrui.[9] La repressione del gioco “privo di significato” diventa così lo specchio di un più ampio impoverimento della vita sociale sotto il capitale.[10]
Unita all’interferenza continua dello stato negli scambi di mercato, unita alle strutture sociali, ai valori culturali e alle relazioni interpersonali, questa privazione nasconde la possibilità di una vita più libera e ampia. Gran parte dei contatti sociali vengono codificati dai residui simbolici della repressione istituzionale. L’assenza di fiducia nelle proprie capacità o in quelle altrui ci rende dipendenti dagli attori politici la cui legittimità si basa spesso su sistemi elettorali corrotti. Monopolizzando il potere decisionale e lo stanziamento delle risorse, limitano le “capacità” del mercato, riducono la rappresentatività dei più deboli e bloccano l’evoluzione delle norme morali.
Per contro un’Attività svolta su un mercato liberato, che esca dai modi di scambio chiusi e falsi imposti dallo stato, può essere realmente sovversiva in quanto genera forme sociali alternative e una realizzazione di sé fuori dalle sfere convenzionali dell’impiego. Potrebbero così nascere fondi di mutuo aiuto con la possibilità, per artisti, studiosi e musicisti indipendenti, di svolgere le proprie attività creative senza adempimenti burocratici e senza l’assillo del bilancio.
Visto così, l’ideale di libero mercato ricorda Giorgio Agamben e il suo gesto che dissolve la contraddizione tra strumenti e fini, una contraddizione che paralizza l’immaginazione morale.[11] Come a dimostrare la natura non coercitiva delle sue interazioni sociali, il libero mercato offre strumenti per vivere che non sono fini a se stessi, e che pertanto conservano la capacità dell’utopia di assorbire le contraddizioni e permettere il cambiamento entro i limiti imposti dalla realtà.[12]
Le nostre traduzioni sono finanziate interamente da donazioni. Se vi piace quello che scriviamo, siete invitati a contribuire. Trovate le istruzioni su come fare nella pagina Sostieni C4SS: https://c4ss.org/sostieni-c4ss.
Note
[1] Ovvero, la capacità di praticare un’attività fisico-intellettuale cosciente e libera: la prassi. Ulteriori note sul concetto e sugli aspetti esistenziali della teoria marxiana della creatività in Кондрашов П. Н. Философия Карла Маркса. Экзистенциально-антропологические аспекты. М., 2024. С 89–117.
[2] Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. М., 2010. С. 335–336. (Testo preso dalla traduzione italiana disponibile qui, NdT).
[3] Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. С. 51–52. URL: https://clck.ru/3FW5BJ.
[4] Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. С. 339. (Traduzione italiana qui, NdT).
[5] Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 2016. С. 61–62.
[6] Kevin Carson, Studies in Mututalist Political Economy. South Carolina, 2011, pp. 74-76.
[7] Sen A. Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny. Cambridge, 2000. pp. 4–6.
[8] Блэк Б. Анархизм и другие препятствия для анархии. М., 2004. С. 21–22.
[9] Cantine H. Art: Play and its Perversions // Retort. Bearsville, New York, Fall 1947. URL: https://theanarchistlibrary.org/library/holley-cantine-art-play-and-its-perversions.
[10] Гудман П. На пути к единодушию. Неверленд, 2024. С. 141–143.
[11] Агамбен Д. Средства без цели. М., 2015. С. 63–64.
[12] Джонсон Ч. Рынки, освобожденные от капитализма. Неверленд, 2024. С. 18–19.