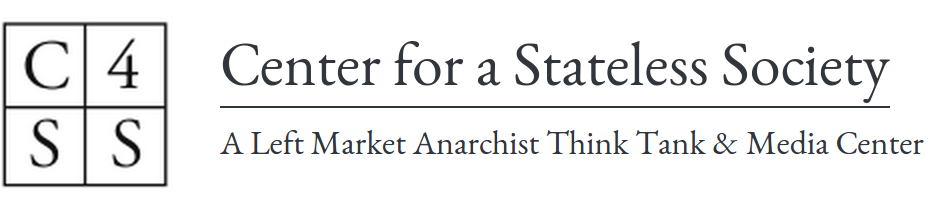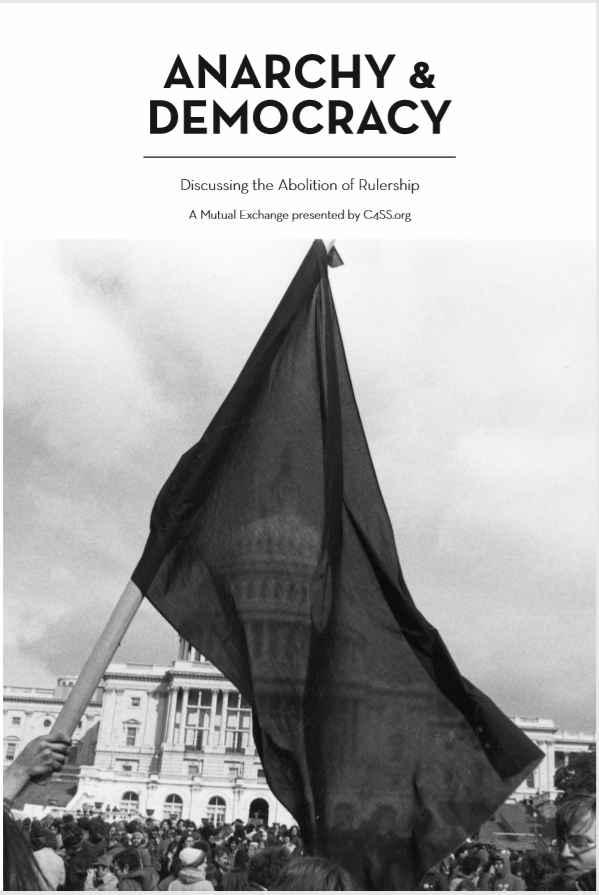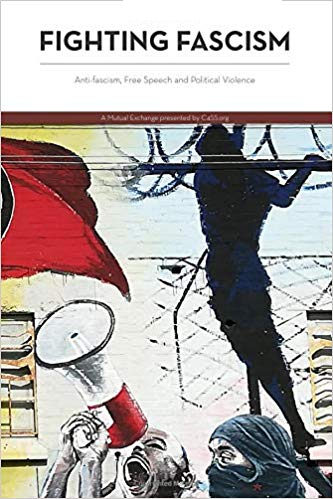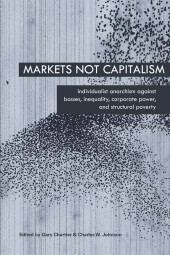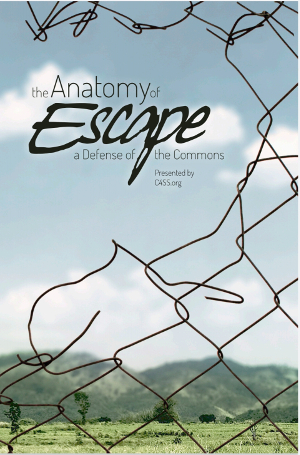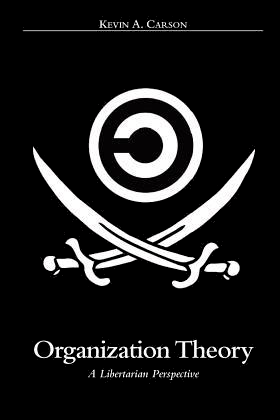Di Vishal Wilde. Originale pubblicato il primo luglio 2025 con il titolo Undemocratic Assumption of Long(er)-Duration Sovereign Debt. Tradotto in italiano da Enrico Sanna.
Una caratteristica peculiare inerente il sistema finanziario internazionale nel ventunesimo secolo è l’apparente necessità di servirsi delle infrastrutture necessarie al debito pubblico (o strumenti simili), come i mercati del credito e i mercati di capitali in generale. In genere, gli stati si servono di questi mercati per prendere prestiti o per finanziare una serie di cose (tramite titoli di stato, prestiti, strumenti debitori alternativi o altro), dalla normale amministrazione alle spese correnti, progetti, programmi, investimenti, copertura di passività e obbligazioni, imprevisti e molto altro. Le normali attività di gran parte di singoli, famiglie, aziende e/o istituzioni sono ben poca cosa se confrontate alla complessità degli stati. Secondo il rapporto 2024 sul debito mondiale del Fmi, “Il debito mondiale (pubblico e privato) nel 2023 ammontava a 250 mila miliardi. … Più due punti percentuale, al 94 percento del pil [ovvero 98 mila miliardi].” La cifra comprende il sistema finanziario parallelo dei paesi islamici, Sukuk, che nel 2024 è arrivato a 1.210 miliardi.
La gamma di fattori su cui voi lettori, o io autore, possiamo confidare per accedere ai fondi con i quali prestatori e investitori valutano la nostra solvibilità (che si tratti di redditi attuali, passati o futuri, impegni preesistenti, patrimoni [netti], precedenti creditizi e finanziari, impiego e così via) non è del tutto diversa dalla gamma di fattori con cui si valutano gli stati, per quanto questi ultimi varino in settori importanti. Sulla base di tante filosofie e teorie politiche, gli stati hanno (o si prendono) spesso il diritto di sottrarre risorse (monetarie, naturali, fisiche, psicologiche e altro) dalla popolazione e dai territori di cui sarebbero responsabili, solitamente entro il quadro dei “diritti di proprietà”. Questa sottrazione di risorse, oggi come in passato e in futuro, è considerata un importante, legittimo segno di solvibilità, assicurando che gli stati in questione sono in grado di onorare i prestiti.
Il debito è la componente dominante della macroeconomia mondiale, da cui molto altro dipende. Ma se andiamo a vedere bene, è ragionevole supporre che in gran parte poggia su premesse indemocratiche e su una finanza pubblica basata sulla sottrazione continuata di risorse da parte dello stato. A prescindere dalla lunghezza dei debiti a breve, medio o lungo termine, i pagamenti hanno cadenza di pochi mesi, o comunque meno di un anno, mentre il debito dura molti anni o anche decenni. Per cui mentre in una democrazia l’incarico di un politico eletto è di cinque o sei anni, con possibilità di rielezione o meno, il debito contratto nello stesso periodo (e in epoche precedenti) può avere durate di dieci, venti, trenta o più anni. Secondo una ricerca di Standard and Poor’s Global del 2024, “Il debito a breve termine nel 2023 rappresentava il 14,8 percento del totale, molto più del 9,5 percento del 2019.” Secondo uno studio pubblicato dall’Ocse nel suo ‘Global Debt Report 2025’ (Panel C of Figure 1.4, page 24), il debito pubblico con scadenza di almeno cinque anni è circa la metà del debito pubblico dei paesi Ocse.
Si nominano funzionari e si eleggono politici, spesso con sistemi problematici o tarati, quasi che questo autorizzasse (in parte) la sottrazione continua di risorse dalla popolazione da parte dei vari apparati dello stato. Anche accettando ciò, credo che sia indemocratico presupporre la continuazione di queste politiche e arrangiamenti sociali dato che il debito pubblico a lung(hissim)o termine non è di per sé, indispensabile al funzionamento della democrazia.
Qualcuno potrebbe ribattere che il debito a lung(hissim)o termine serve a bilanciare l’insieme delle passività originate dagli obblighi debitori (ottimizzare i pagamenti futuri con un giusto mix di debiti). Ma questo non dimostra che questa forma di indebitamento è strettamente indispensabile al funzionamento corretto di una democrazia, se non, indirettamente, per dimostrare, estrapolando dal contesto, cosa significa avere una situazione finanziaria in ordine. Quando si contrae un debito che va oltre la durata del mandato elettorale (che si tratti di persone elette direttamente o indirettamente) si dà per scontato che la popolazione acconsenta alla sottrazione di risorse anche al di là del termine di tale mandato. Perché la popolazione debba acconsentire esplicitamente non è chiaro, se non perché forse lo si ritiene un fatto inevitabile (il che, direbbero molti, non significa consenso esplicito). Detto più semplicemente, un conto è emettere un mutuo da pagare in 15, 20, 30 o 40 anni sulla base del reddito futuro possibile al netto delle deduzioni come la succitata sottrazione di risorse da parte dello stato e altre entità; tutt’altra cosa è misurare la solvibilità di un’entità dando per scontato che la società non cambi e che non cessi il diritto dello stato di imporre la sottrazione di risorse sulla popolazione e i suoi territori. Il che non è necessariamente problematico per un regime autoritario, una dittatura, una teocrazia o uno stato totalitario, ma sistemicamente viziato e potenzialmente immorale per una presunta democrazia.
Le dimensioni del debito pubblico, gli interessi e la durata hanno un forte impatto sulla struttura e le attività dell’economica mondiale. Se, ad esempio, prestare ad uno stato è considerato “meno rischioso” o “più affidabile”, quasi “a rischio zero”, rispetto ad un prestito dato ad un’impresa o un individuo, questo non può non influire sulla distribuzione del debito e delle risorse a livello macroeconomico. Similmente, il fatto che esistano stati giudicati “meno a rischio” o “più affidabili” rispetto ad altri influisce sul flusso di capitali e la distribuzione del debito a livello internazionale. Tutto ciò finisce per determinare la spesa, gli investimenti, gli acquisti, le vendite, la finanza, il commercio mondiale, gli equilibri e gli squilibri, le strutture industriali e altro. Direi che si tratta, non tanto di un effetto domino, anche se lo comprende, ma, estendendo la metafora, di qualcosa che determina la forma, la profondità, i limiti, la composizione e la vita stessa di quegli oceani che sono le economie, i capitali e i mercati del credito.
È difficile immaginare (in modo certo) cosa potrebbe accadere in assenza di tale debito. Cercherò di fare qualche congettura e/o ipotesi. Se crescesse la domanda di debito da ripagarsi entro la legislatura, e quindi diminuisse il debito di (più) lunga durata, l’effetto potrebbe essere la riduzione degli interessi, si attenuerebbe la necessità di prendere dalla popolazione. Il risultato potrebbe essere che chi possiede fondi prestabili cercherebbe altre sbocchi, come il prestito alle famiglie, ad aziende o ad altre istituzioni (potenzialmente a tassi inferiori agli attuali) con strumenti finanziari e altro, modificando così le strutture distributive del debito interno e tra singole economie. Se si riduce l’offerta di debito pubblico, e se il debito pubblico di molti paesi è “meno rischioso” o quasi “senza rischio”, può crescere l’incentivo a valutare più attentamente il rischio, potrebbero esserci più opportunità d’investimento, con prestiti o altrimenti. Rispetto allo stato attuale, la disponibilità mondiale di crediti e fondi, anche in quei paesi o presso quelle categorie spesso poco interessate o rappresentate, potrebbe produrre effetti profondi.
Fatto importante, il debito pubblico a lung(hissim)o termine (meglio: quello che giunge a maturazione dopo la scadenza di un mandato elettorale) si basa su una sottrazione continuata di risorse da parte degli stati e dei loro apparati, comprese le indispensabili strutture socioeconomiche, contribuendo così a legittimare tale forma di indebitamento sulla base di impliciti sottintesi indemocratici.
Le nostre traduzioni sono finanziate interamente da donazioni. Se vi piace quello che scriviamo, siete invitati a contribuire. Trovate le istruzioni su come fare nella pagina Sostieni C4SS: https://c4ss.org/sostieni-c4ss.