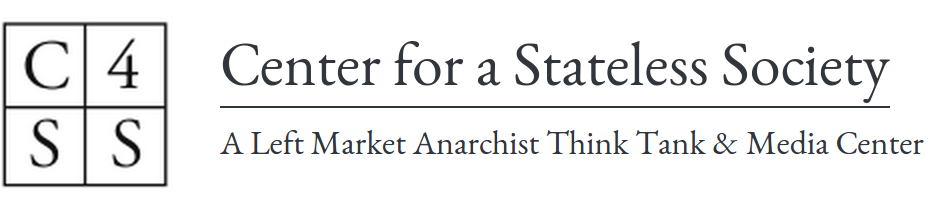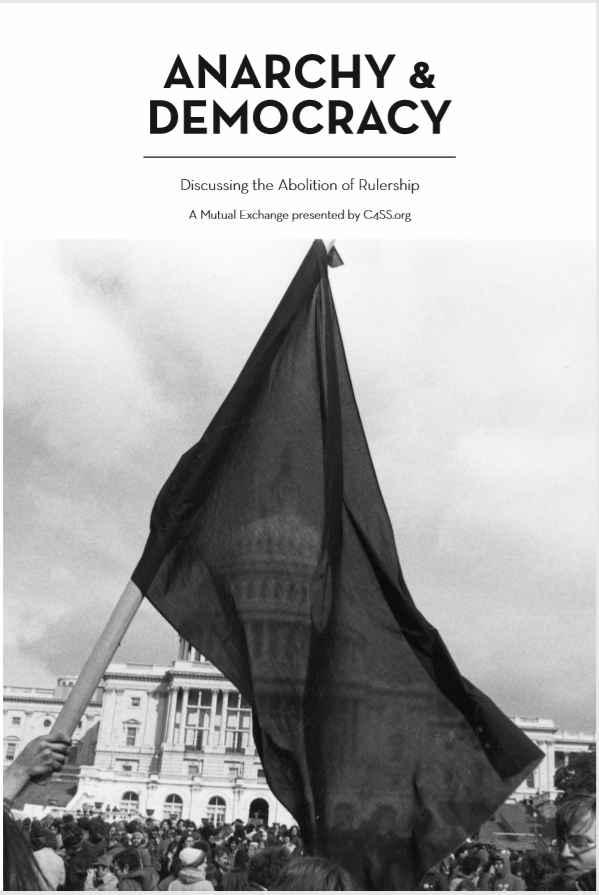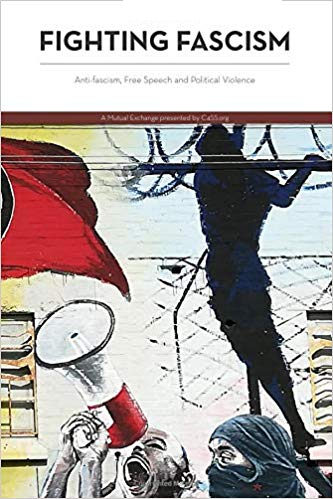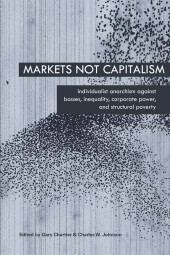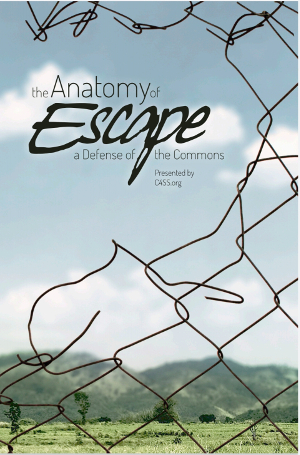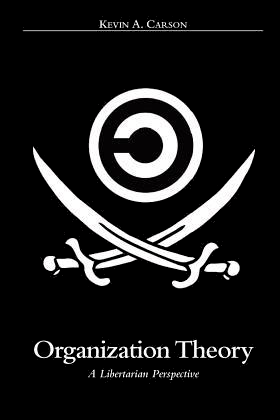Di Kevin Carson. Originale: Degrowth: The Conceptual Confusion Continues, del primo aprile 2025. Tradotto in italiano da Enrico Sanna.
In un saggio scritto nel 2019 per il Center for a Stateless Society (We Are All Degrowthers. We Are All Ecomodernists), sostenevo la quasi incoerenza del discorso a favore o contro la decrescita perché nessuna delle parti si preoccupa di definire chiaramente il concetto di “decrescita”, né tantomeno mantiene una definizione coerente. E Paul Crider (“Degrowth: Neither Left Nor Right, But Backward”, Liberal Currents, 12 dicembre, 2022) non fa che confermarlo. Bisogna però ammettere che la sua critica della decrescita appare molto più in buona fede rispetto a Leigh Phillips (di cui analizzo il pensiero nel saggio citato più su), e non pratica una lettura faziosa dei testi sulla decrescita come invece fa Phillips (per intenderci, Crider si definisce liberal mentre Phillips è un accelerazionista di sinistra).
L’avvio di Crider è promettente:
Il termine [decrescita] in sé è sconcertante. A chi crede negli ideali della crescita economica e sa quanto una sua contrazione, la recessione, sia associata a paure e sofferenze, la decrescita fa pensare a una politica autodistruttiva, se non a un ritorno ad un mondo primitivo.
Eppure la decrescita merita un ascolto. Vorrei spiegare perché l’ideale della decrescita è destinato a fallire, ma vorrei anche dire che le sue tante correnti sono spesso incomprese, confuse o male illustrate. Ha ragione quando dice che il prodotto interno lordo (pil) è un indicatore fallace; così come quando spiega che la crescita economica come obiettivo principale, nonostante sia universalmente accettata, non è chiaramente giustificata in termini liberali o altro; e infine quando dice che la crescita economica comporta conseguenze che possono arrivare all’assurdo.
La critica di Crider sbanda, primo, per problemi legati alle fonti, e, secondo, per una scarsa chiarezza concettuale dovuta a una cattiva interpretazione delle fonti stesse. Cominciamo dal primo:
Vediamo quello che dicono gli esponenti della decrescita. Gran parte del mio saggio prende The Future Is Degrowth: a Guide to a World Beyond Capitalism, di Matthias Schmelzer, Aaron Vansintjan, e Andrea Vetter, come fonte di informazioni chiara e valida sulle varie correnti all’interno del movimento decrescentista. Iniziamo riferendoci ad un saggio particolarmente utile.
Quindi Crider cita questo passo:
Un prezioso sondaggio sui sostenitori della decrescita, fatto in occasione della conferenza di Lipsia del 2014 in cui era coinvolto anche uno dei sottoscritti, evidenzia queste posizioni largamente condivise: una crescita economica senza distruzione della natura è un’illusione, i paesi industrializzati dovrebbero scalare in maniera equa produzione e consumo; pertanto i ricchi dovrebbero rinunciare a certi lussi; infine, il passaggio ad una società della decrescita deve venire dal basso, dev’essere pacifica e deve comportare il superamento del capitalismo e del patriarcato. Questo consenso unisce partecipanti alla conferenza di vedute diverse, e sottolinea come i sostenitori della decrescita siano fondamentalmente critici verso la crescita, il capitalismo e l’industrialismo, vogliono il superamento di altre forme di dominio e una ristrutturazione di fondo dell’economia dei paesi industrializzati con una contrazione selettiva di certi settori industriali e di certe produzioni. È questo che distingue la decrescita da altre posizioni radicali; non solo dal pensiero conservatore (come il mantenimento della situazione attuale, il fascismo verde e la crescita verde), ma anche da certe posizioni produttiviste di sinistra, come gran parte del Green New Deal o certe fantasie post-capitaliste, posizioni che a proposito della necessità di cambiare il capitalismo, le dinamiche della crescita e il consumo eccessivo restano sul vago.
Il problema di questa citazione (a parte che si tratta di un sondaggio fatto tra i partecipanti a una conferenza a Lipsia, e dunque le conclusioni valgono solo per il movimento decrescentista tedesco) è che, come dice lo stesso Crider, la decrescita è un movimento con “tante correnti”, e le posizioni contrastanti che emergono dalle dichiarazioni citate non provengono necessariamente dalla stessa persona. Se è vero che la maggioranza (non si sa quanto grande) delle persone intervistate concorda con le singole frasi, non è detto che si tratti sempre della stessa maggioranza. Inoltre molti termini, soprattutto “industrialismo”, sono vaghi e possono essere interpretati in modo diverso da persone diverse.
Nel testo in questione, gli autori di The Future is Degrowth citano due fonti:
1. Matthias Schmelzer e Dennis Eversberg, “Beyond Growth, Capitalism, and Industrialism? Consensus, Divisions and Currents within the Emerging Movement for Sustainable Degrowth,” Interface: A Journal for and about Social Movements 9, no. 1 (2017), 327–56;
e
2. Dennis Eversberg and Matthias Schmelzer, “The Degrowth Spectrum: Convergence and Divergence within a Diverse and Conflictual Alliance,” Environmental Values 27, no. 3 (2018), 245–67.
Dei due, solo il secondo è disponibile su Sci-Hub.
A ben vedere, nessuna delle domande del sondaggio definisce chiaramente i termini “crescita” e “decrescita”, né chiede agli intervistati se sono d’accordo o meno. Alcune domande parlano vagamente di limitazione di “produzione e consumo”, o di “contrazione”, senza specificare cosa si intende con questi termini. La parola “industrialismo”, inoltre, non compare affatto, il che solleva forti dubbi sulle conclusioni tratte da Schmelzer e altri.
La risposta più imbarazzante, per chi vuole sfatare il nesso tra decrescita e austerità, è probabilmente la frase “In futuro saremo costretti a rinunciare alle comodità a cui siamo abituati”, con cui concordava l’86% degli intervistati. Si tratta però di una frase molto vaga. Molte delle comodità a cui dovremmo rinunciare sono in realtà cose che siamo costretti a consumare per compensare la perdita di altri comfort di cui siamo stati privati. L’automobile è un ottimo esempio. L’auto è stata resa obbligatoria dalla distruzione dei vecchi centri urbani, in cui tutto era a portata di mano, ci si poteva muovere o a piedi e i mezzi pubblici erano più che sufficienti. Quanto alle altre comodità, oggi produrle con profitto è possibile solo a livelli artificialmente alti, oppure sono accessibili solo grazie ad incentivi economici. In tal caso, incorporando pienamente i costi nei prezzi si avrebbe una riduzione automatica dei consumi.
D’altro canto, quasi due terzi degli intervistati concorda con l’affermazione “Il forte sviluppo tecnologico dell’attuale società non è un freno, ma un’importante precondizione di una società post-crescita.” Più di due terzi pensa che non si debbano proibire i voli turistici a lunga distanza. La maggioranza non crede a un “ritorno alla natura”, mentre a concordare con l’affermazione “Per vivere in modo più sostenibile dovremmo tornare a uno stile di vita del passato” è poco più della metà.
Dunque, i numeri di questo sondaggio smentiscono la tecnofobia dei sostenitori della decrescita (come parrebbe, data la loro avversione verso il “produttivismo di sinistra”, un pensiero che forse riflette una visione della tecnologia da culto del cargo).
A partire da questo punto, il problema sta soprattutto nell’opacità concettuale di Crider.
Riprendendo un avvio promettente, evidenzia i problemi derivati dal fatto di usare il pil come indicatore.
A prima vista, la crescita economica è rappresentata dal pil, il prodotto interno lordo, che in principio rappresenta il totale della produzione economica, l’insieme di quanto si spende o si guadagna. La decrescita sottolinea i limiti di quello che è l’indicatore economico di riferimento dei politici, e ne chiede l’abolizione. Il pil è un bersaglio facile, ma la decrescita è contro la crescita economica anche in senso più ampio.
Il pil non tiene conto né del degrado ambientale né della ricchezza rappresentata dalle risorse naturali. Stravolgere il territorio e il suo equilibrio ecologico per estrarre carbone (e aumentare le emissioni di gas serra) per il pil risulta è un guadagno non solo netto ma anche assoluto.
Altre assurdità riguardano l’attività domestica e riproduttiva. La prima, cura della casa, dei bambini o degli anziani, non figura nel pil se non quando c’è uno scambio monetario…
Salute e benessere figurano nel pil solo come acquisto di medicine, cure ospedaliere o visite terapeutiche. Se il cibo spazzatura e le attività dannose si diffondono, il pil cresce prima con le vendite e dopo (ripetutamente) con le spese mediche necessarie a riparare il danno…
Ma nei due paragrafi seguenti Crider quasi rovina tutto.
Il pil non considera né la varietà di scelta né i beni e i servizi di nuovo tipo. Per il pil una scarpa resta una scarpa, mentre c’è differenza in termini di stile di vita non solo tra una marca e l’altra ma anche tra i diversi modelli come le scarpe di alta moda, hi-tech da corsa o antinfortunio. Quanto alle novità assolute, basta pensare alla rivoluzione digitale resa possibile dalla crescita economica.
Se critici e sostenitori della crescita trovano spesso utile fare riferimento al pil, la preoccupazione principale della decrescita è la crescita intesa come produzione fisica, il “metabolismo sociale”, il rapporto reale, materiale e energetico che l’uomo ha con la natura. Mi riferisco a questo vasto fenomeno parlando di “crescita economica materiale”.
Quest’ultimo paragrafo spiega correttamente il concetto di crescita e spiega anche perché, dal punto di vista della decrescita, è problematica. Il pil non è altro che il valore di scambio totale, che all’atto pratico è la somma dei costi di produzione e delle rendite. Riducendo le risorse necessarie a produrre qualcosa di un certo valore d’uso si riduce proporzionalmente il pil, a meno che la rendita derivante da scarsità artificiale o da diritti artificiali di proprietà impediscano ai costi di produzione di avere effetto sul prezzo finale di beni e servizi. L’obiettivo centrale della decrescita è una riduzione delle risorse impiegate nella produzione, mentre è indifferente alla produzione di valore d’uso. Questo significa che, a seconda di come cambia l’efficienza produttiva e il design, una riduzione dei costi di produzione può ridurre il pil senza necessariamente influire sullo stile di vita.
Messo in questo contesto, il penultimo paragrafo elabora il principio presentato nell’ultimo (pur aggiungendo un po’ di confusione). Il pil “non dice nulla riguardo la varietà di scelta e l’invenzione di nuovi beni e servizi”. La qualità di questi ultimi può migliorare senza alcun effetto sul pil.
Ma poi Crider aggiunge che la rivoluzione digitale e la crescita della potenza di calcolo sono state rese possibili “dalla crescita economica”. Crider commette lo stesso errore di Leigh Phillips e di altri detrattori della decrescita che considerano la “crescita” più o meno sinonimo di “progresso”, e non, come dovrebbe essere ovvio, crescita del valore di scambio aggregato, soprattutto in termini d’impatto e non di valore d’uso.
Ciononostante, Crider continua a parlare di “crescita” come se fosse, se non sinonimo di impatto fisico e consumo di risorse, almeno qualcosa di molto simile.
La decrescita, liberale o non, offre buone ragioni per criticare il cosiddetto “obbligo della crescita”. Noi rischiamo una catastrofe ecologica, che può essere affrontata seriamente solo riducendo drasticamente il nostro metabolismo sociale. La crescita materiale comporta una pressione crescente sulla natura. La cosa è tanto più evidente con i combustibili fossili da cui fin dall’inizio della Rivoluzione Industriale dipende la crescita economica. È anche vero però che in quest’ultimo decennio si è diffuso un certo ottimismo sull’allontanamento della produzione energetica, e dunque dell’economia in generale, dai combustibili fossili che emettono gas serra: l’energia rinnovabile si prepara a superare quella prodotta dal carbone entro il 2025 grazie al calo continuo dei costi del solare. L’idea di azzerare le emissioni nette è ambiziosa ma non più impossibile, l’Inflation Reduction Act di Biden, tanto per citare un promettente esempio recente, pone le basi di una grande infrastruttura energetica pulita.
Da notare che “ridurre il metabolismo sociale” e separare il consumo di risorse dalla produzione di valore d’uso sono il programma della decrescita. Ma poi Crider cambia rotta, e lo fa semplicemente sulla base delle conclusioni di Schmelzer e altri sul sondaggio citato più su:
Finché la decrescita cerca di separare la crescita economica da cose come la salute, lo sviluppo e la ricchezza, la sua azione è un utile correttivo. Ma la decrescita dice anche che la crescita non è tutto, non solo ma anche che è irrilevante o, in un’ottica di estrema sinistra, semplicemente dannosa. Per quanto la decrescita liberale si dichiari neutrale nei confronti della crescita, molte correnti della decrescita sono contro il capitalismo, l’industria e l’abbondanza; insomma, sono antiliberali…
Secondo la decrescita, ai soggetti della crescita, persone normali che vivono una vita normale in una democrazia liberale, occorrerebbe insegnare a limitare le proprie aspirazioni. Ma perché si dovrebbe rinunciare alle novità, al cibo, allo sport e così via? Perché rinunciare a viaggiare, a leggere, ai cibi esotici, ad un hobby costoso?
Ad aggiungere confusione, la prima frase contraddice tutto il resto.
All’inizio Crider riconosce i vantaggi teorici della separazione tra “crescita” e benessere materiale; ma subito dopo dice che decrescita significa frugalità, da imporre con la pianificazione centrale e il controllo sociale. Quest’ultima accusa è tanto esplicita quanto stridente.
…[P]ortata alle sue conseguenze logiche, la decrescita diventa pianificazione centrale e controllo sociale. Con la decrescita, la naturale propensione a soddisfare i nostri bisogni con lo scambio o la compravendita diventa sospetta, se non deprecabile. Il profitto, l’investimento, il consumo, e anche il risparmio, sono tutte cose che si fanno per migliorare la propria vita e le possibilità della propria famiglia, degli amici o della comunità. L’impulso a migliorare la propria vita è così forte e importante che deve essere instradato o assoggettato a controllo.
Per Crider, non è immaginabile uno scenario stabile se la stragrande maggioranza delle persone, delle aziende e degli stati sceglie di ridurre ricchezza e capacità produttiva, in pratica di impoverirsi, spontaneamente…
…Un sostenitore della decrescita potrebbe rispondere dicendo che la “libertà” umana è il prezzo da pagare per evitare la catastrofe ecologica. Ma anche in questi termini la decrescita è destinata a non soddisfare le esigenze primarie a cui dà tanta importanza. Se c’è una lezione che abbiamo imparato dalla storia è che le economie a pianificazione centrale non riescono a soddisfare i bisogni di base o a difendere i diritti di base dei propri soggetti. Le mie accuse contro la pianificazione centralizzata non sono antisocialismo preconcetto contro la pubblica amministrazione. Penso infatti che la spesa pubblica sia imprescindibile se si vuole affrontare i cambiamenti climatici, e sono a favore di uno stato che offra una “opzione pubblica” in materia di sanità, assistenza all’infanzia, banche, trasporti e altri servizi, offrendo così le basi perché tutti vivano una vita produttiva e prospera. Forse è socialismo o forse no, ma certo non è pianificazione centrale. In quest’ultimo caso le scelte quotidiane in fatto di consumi e produzione aziendale sono viste con sospetto, e vietate se non hanno l’approvazione da parte di consigli “democratici”.
A sostegno della sua tesi, cita The Future is Degrowth:
Perché [la decrescita] diventi realtà, le scelte economiche devono diventare questioni politiche. Questo significa mettere l’economia nelle mani della gente, coinvolgere sempre più persone nelle decisioni chiave. I produttori di una fabbrica, i confinanti di un’azienda agricola, i pensionati che stanno in un ospizio: tutti questi devono avere voce sulla produzione, sul rapporto con l’ambiente e con gli agenti economici, sui servizi e sull’organizzazione del lavoro.
E continua sulla stessa linea:
Alla presunzione di libertà, fare ciò che si vuole, comprare, vendere e scambiare ciò che si vuole e lavorare quanto si vuole, si sostituisce la presunzione che ogni cosa debba essere approvata da un’autorità. Questa è la politica economica delle associazioni di vicinato a livello locale, mentre a livello nazionale (e internazionale) si scelgono quali settori economici ripulire per il “bene comune” della decrescita. Quanto alle industrie rimanenti, il potere politico sceglie quali prodotti e quali produttori sono veramente necessari e quali devono essere eliminati perché sono uno spreco…
Bisogna riflettere su cosa significherebbe, in termini umani, il passaggio ad un’economia a comando e controllo. La decrescita potrebbe portare al posto di lavoro garantito, ma la possibilità di scelta diminuirebbero drasticamente. Volete stare con la famiglia? Volete studiare letteratura tedesca o economia? Ogni decisione dovrà essere approvata dai pianificatori, soprattutto quando i piani quinquennali di decrescita cominceranno a mancare gli obiettivi.
Dopo aver detto e ripetuto che la decrescita richiede una pianificazione di tipo staliniano, Crider continua equiparando sciattamente “crescita”, “progresso” e “innovazione”, pur avendo ammesso in precedenza che le ultime due possono essere separate dal pil e dal consumo delle risorse (in pratica, non hanno niente a che fare con la “crescita”):
Gli effetti sulla crescita economica sarebbero negativi. La decrescita comporterebbe costi insostenibili in termini di libertà. Crescita economica fisica significa anche ampliamento delle possibilità. Più ricchezza, più capacità produttiva e innovazione moltiplicano i modi in cui l’individuo può realizzare i propri progetti e le proprie ambizioni. La crescita necessita della libertà e la libertà della crescita. Le due cose sono inseparabili.
Sono tante le invenzioni che hanno migliorato drasticamente le capacità dell’uomo. Mi viene in mente la pillola, che più di tutto l’edificio dottrinale femminista forse ha contribuito a liberare la vita pubblica delle donne e a erodere il patriarcato. Ma questo ha richiesto un minimo di capacità economica per una produzione su larga scala. O la terapia ormonale per i transessuali, che non sarebbe mai nata se la decrescita fosse iniziata nell’Ottocento. Il covid avrebbe avuto ben altre conseguenze, e sarebbe stato impossibile continuare a lavorare (bisogna lavorare anche con la decrescita), se l’industria farmaceutica non fosse stata pronta a sfornare milioni di dosi di vaccini mRNA. La Rivoluzione Verde ha permesso di sfamare miliardi di persone e l’ingegneria genetica promette di continuare sulla stessa strada. La sanità potrebbe essere rivoluzionata da tecnologie avanzatissime come le CRISPR, che come piattaforma tecnologica darà probabilmente vita a tutto un nuovo settore industriale.
Per inciso, tutto questo è contraddetto dal movimento tedesco della decrescita, che pensa quasi all’unanimità che l’attuale tecnologia aiuti la decrescita.
Quindi Crider torna al tema della separazione tra “crescita” come crescita del pil e progresso tecnologico:
Noi non sappiamo quali tra le prossime tecnologie avranno la stessa importanza del controllo delle nascite o della telefonia mobile. Possiamo però ammettere che la crescita economica materiale può portare a simili rivoluzioni senza massimizzare il pil a tutti i costi.
Ma subito dopo ecco che torna a paragonare la decrescita con tutto ciò che è sottosviluppato e primitivo, e in termini che indicano sofferenza.
Le buone idee presenti nella decrescita (gruppi di astensione dagli acquisti, librerie, servizi di base universali, giustizia sociale totale) sono fattibili anche con la crescita. La decrescita aggiunge di suo solo concetti marci: pianificazione centrale, politicizzazione delle scelte economiche quotidiane e dello stile di vita e un calo drastico delle aspettative: nessuna possibilità di crescita e miglioramento di se stessi, semplicemente stare accucciati in casa.
Così finisce l’articolo di Crider. Il suo problema si divide in due linee generali.
La prima è ovviamente l’incoerenza concettuale. Spiegare non serve, abbiamo già visto come la sua descrizione della decrescita cambia da un paragrafo all’altro.
La seconda è che immagina, senza una ragione, che la decrescita richieda l’“imposizione di limiti” tramite una “pianificazione centrale”, e non tramite, poniamo, l’eliminazione di tutti i modi in cui lo stato incentiva il consumo di risorse e pone barriere all’efficienza. Crider vede la cosa alla maniera di molti liberali filocapitalisti: tutto ciò che la sinistra critica del capitalismo (come la disuguaglianza, lo sfruttamento, gli schemi di estrazione del profitto, l’insostenibile consumo di risorse e così via) è frutto spontaneo del mercato e può essere cambiato solo intervenendo attivamente e imponendo costrizioni dall’esterno.
È vero il contrario. Capitalismo e stato nazionale sono entità gemelle, nascono insieme agli inizi della modernità e fin da subito sviluppano una relazione simbiotica. Tutti i tratti distintivi del capitalismo, come l’esproprio della terra e le chiudende, l’allontanamento di gran parte della popolazione dai mezzi di sussistenza, l’imposizione di massa del sistema salariale e del nesso di cassa, la trasformazione di terra e lavoro (nel senso inteso da Polanyi) in “beni fittizi”, tutto ciò ha richiesto la violenza costitutiva dello stato. Il capitalismo necessita del continuo intervento violento dello stato: gran parte dei profitti deriva da rendite da diritti di proprietà e scarsità artificiali (proprietà assenteista, proprietà intellettuale, limitazione per legge della funzione creditizia a chi già possiede ricchezza accumulata e così via), ed è grazie a queste rendite che la ricchezza accumulata può crescere esponenzialmente.
Importantissimo, ai nostri fini, è il modo in cui il capitalismo, fin da subito, ha perseguito uno schema basato sulla crescita infinita attraverso l’utilizzo massiccio di risorse artificialmente a basso costo. Una delle funzioni principali dello stato capitalista, a cominciare dall’esproprio coloniale delle risorse a vantaggio esclusivo del capitale occidentale, è garantire la fornitura di materie prime a basso costo. In seguito è venuta l’imposizione di uno sviluppo basato sulle esportazioni e la fornitura di materie prime coloniali all’Occidente, e l’imposizione di schemi economici orientati all’esportazione nel sud del mondo tramite istituzioni multilaterali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario, e grazie al ruolo degli Stati Uniti e dei loro alleati subordinati nelle guerre per il petrolio e nel rovesciamento quei governi che si allontanavano dalla chiesa neoliberale.
A livello nazionale lo stato ha incentivato una crescita estensiva basata su risorse a costo artificialmente basso, come scriveva molto tempo fa James O’Connor in The Fiscal Crisis of the State. Oltre alle guerre per il petrolio e al ruolo primario della marina militare nella protezione delle petroliere a spese dei contribuenti, anche l’aviazione civile e il sistema autostradale sono quasi interamente opera dello stato. Senza queste cose, se gran parte dei costi non fosse stato girato ai contribuenti, l’attuale estesa rete logistica capitalista sarebbe stata impossibile.
È sempre lo stato, inoltre, a rendere possibile la massimizzazione della produzione industriale grazie a consumi distruttivi come l’economia industrial-militare, l’incentivo della cultura dell’auto e dell’espansione urbana e, con i brevetti, l’obsolescenza programmata.
Contrariamente a come la vede Crider, si può ottenere la decrescita rapida del consumo distruttivo e dello spreco di risorse togliendo gli incentivi. In fin dei conti, molto più della pianificazione centrale sarebbe molto più pratico eliminare gli incentivi perversi tramite la predistribuzione: incorporandoli nella struttura istituzionale di base e nella definizione dei diritti di proprietà e lasciando che siano i prezzi di mercato a risolvere la questione, così che il sistema sarebbe molto più efficiente che non con la pianificazione centrale. Alle pagine 14-24 del mio saggio Hayek’s Fatal Conceit (C4SS, 2020) propongo un sistema predistributivo hayekiano e socialista di mercato sulla base di una ridefinizione dei diritti di proprietà.
Ho sollevato queste questioni con Crider in forma molto più breve (entro il limite di trecento caratteri) su Bluesky il quattro aprile scorso. Ne è risultato un interessante scambio di opinioni (il link funziona solo se si ha un account su Bluesky).
Crider mi ha spiegato che “i sostenitori della decrescita parlano di limiti da imporre. Dicono che bisogna eliminare il ‘consumo eccessivo’ e le ‘industrie superflue’. Il diavolo sta nei dettagli, e in chi prende le decisioni.”
Gli ho fatto notare che “spesso gli anticapitalisti prendono alla lettera espressioni come ‘capitalismo senza restrizioni’, non sanno quanto gli schemi di profitto dipendono dall’esproprio dei beni comuni, dalla scarsità artificiale e da normative e sussidi vari.”
Cosa ancora più importante, le espressioni tra virgolette non significano affatto che occorrono limitazioni esterne per eliminare il sovraconsumo o le produzioni industriali inutili. Quando si dice che occorre una pianificazione centrale, ci si riferisce unicamente alla realtà del capitalismo attuale. Come abbiamo visto, è lo stato capitalista che con intervenendo direttamente incentiva sprechi e irrazionalità, il problema potrebbe essere risolto eliminando quell’intervento.
Crider infine accusa: “la decrescita comporta un’economia del sospetto: ogni nuova attività economica, in tutte le sue fasi, dev’essere giustificata. Nel mio saggio fornisco prove testuali di questa economia del sospetto.”
Ci siamo già soffermati più su sulla qualità di queste “prove testuali”. Le uniche prove dirette citate sono uno o due riferimenti alla critica dell’“industrialismo” e “certe posizioni produttiviste di sinistra” prese brevemente da The Future is Degrowth. Come abbiamo già visto, l’uso di un certo linguaggio per caratterizzare i sostenitori della decrescita è quasi interamente frutto dell’interpretazione fatta dagli autori del saggio, non trova conferma nelle risposte date alle domande poste nel sondaggio.
Quanto all’affermazione “le scelte economiche devono essere considerate problemi politici”, contenuta in The Future is Degrowth, si tratta semplicemente dell’opinione dei suoi autori, niente fa pensare che rifletta l’opinione generale di un movimento. Definire le scelte economiche “problemi politici” non significa che spetta allo stato fare da controllore; politica è la scelta di affidare allo stato, e fino a che punto affidarlo, il ruolo di controllore. La questione potrebbe essere risolta a priori, ad esempio se proprietà e gestione aziendale sono dei lavoratori e se le risorse naturali sono gestite da entità collettive del tipo delineato da Elinor Ostrom, non con la pianificazione centrale. Come minimo, si avrebbe una distribuzione molto più razionale dei diritti di proprietà e meno incentivi perversi rispetto all’attuale sistema. Si manterrebbe così la compatibilità con la formazione di prezzi di equilibrio e con un’equa distribuzione dei beni.
Su ciò che comporta l’obiettivo finale della decrescita non ci sono prove testuali, solo le supposizioni di Crider.
Come sostengo nel mio saggio pubblicato dal C4SS, la colpa di ecomodernisti, decrescitisti e antidecrescitisti è che fanno una parodia di dibattito sulla crescita. Sono colpevoli di sciatteria concettuale, usano i termini “crescita” e “decrescita” in modo ambiguo, non li definiscono mai in modo preciso e coerente. Dietro le parole più frequenti, è però possibile almeno intuire una definizione più o meno coerente.
Per i sostenitori della decrescita, la definizione implicita di decrescita, al di là della sciatteria e incoerenza di cui sopra, è la riduzione del consumo totale delle risorse e del pil, in quanto misura aggregata del valore delle risorse consumate a prescindere dallo standard di vita. Per i loro detrattori, “decrescita” significa arretramento economico e tecnologico e austerità, che Crider definisce figurativamente come un “fermare il motore economico e mettere la retromarcia”.
Perché il dibattito vada avanti, i decrescentisti dovrebbero prima chiarire a se stessi cosa comporta la logica delle loro proposte e poi agire seguendo tale logica in modo coerente. Quanto ai loro detrattori, invece, dovrebbero criticare queste proposte, non proposte di comodo. Entrambi dovrebbero arrivare ad un punto d’accordo su come separare lo standard di vita dal pil e dal consumo di risorse, ed eliminare gli sprechi e le irrazionalità insite nella produzione di ciò che serve.
Le nostre traduzioni sono finanziate interamente da donazioni. Se vi piace quello che scriviamo, siete invitati a contribuire. Trovate le istruzioni su come fare nella pagina Sostieni C4SS: https://c4ss.org/sostieni-c4ss.